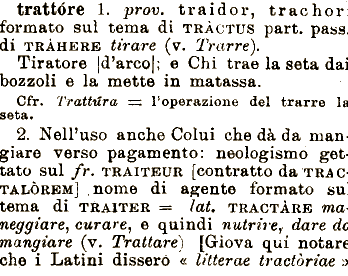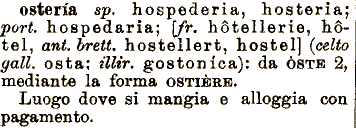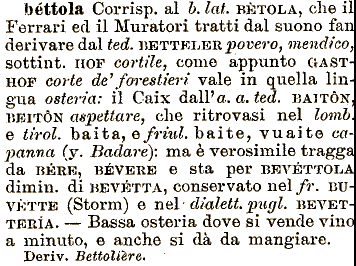Preparo una lezione su un libro di Antonio Tabucchi, La testa perduta di Damasceno Monteiro (1997, Feltrinelli), il quale esordisce così:
«Manolo il Gitano aprì gli occhi, guardò la debole luce che filtrava dalle fessure della baracca e si alzò cercando di non fare rumore. Non aveva bisogno di vestirsi perché dormiva vestito, la giacca arancione che gli aveva regalato l'anno prima Agostinho da Silva, detto Franz il Tedesco, domatore di leoni sdentati del Circo Maravilhas, ormai gli serviva da vestito e da pigiama. Nella flebile luce dell'alba cercò a tentoni i sandali trasformati in ciabatte che usava come calzature. Li trovò e li infilò. Conosceva la baracca a memoria, e poteva muoversi nella semioscurità rispettando l'esatta geografia dei miseri mobili che la arredavano. Avanzò tranquillo verso la porta e in quel momento il suo piede destro urtò contro il lume a petrolio che stava sul pavimento. Merda di donna, disse fra i denti Manolo il Gitano. Era sua moglie, che la sera prima aveva voluto lasciare il lume a petrolio accanto alla sua branda con il pretesto che le tenebre le davano gli incubi e che sognava i suoi morti. Con il lume acceso basso basso, diceva lei, i fantasmi dei suoi morti non avevano il coraggio di visitarla e la lasciavano dormire in pace.
-Che fa El Rey a quest'ora, anima in pena dei nostri morti andalusi?
La voce di sua moglie era pastosa e incerta come di chi si sta svegliando. Sua moglie gli parlava sempre in geringonça, un miscuglio di lingua dei gitani, di portoghese e di andaluso. E lo chiamava El Rey. La voce di sua moglie era pastosa e incerta come di chi si sta svegliando. Sua moglie gli parlava sempre in geringonça, un miscuglio di lingua dei gitani, di portoghese e di andaluso. E lo chiamava El Rey».
Giusto per raccapezzarci un poco sull'uso odierno di alcune parole in Italia...
Le parole che in Italia servono a denominare un certo gruppo di persone sono : zingaro, rom, nomade, gitano, tzigano (più raro: zigano). Sono messi in ordine di diffusione nell’uso comune, ma non tutti sono politically correct. Da ricordare comunque che vengono usati un po’ tutti, questi termini. Gitano e tzigano sono usati in senso poetico. Rom è un termine usato spesso in campo giudiziario. Nomade in campo giornalistico. Zingaro è trans-settoriale.Zingaro
zingaro [zìn-ga-ro] s.m. (f. -ra)
1 Appartenente a un gruppo etnico originario dell'India, stanziatosi successivamente anche in Europa e nel resto del mondo, che conduce vita perloppiù nomade: accampamento di zingari
2 In similitudini e usi fig., persona girovaga, incline o soggetta a continui cambiamenti di sede: condurre una vita da z.; con valore spreg., persona dall'aspetto trascurato: così disordinato, sei proprio uno zingaro!
- • dim. zingarello
• sec. XV
è spesso usato in senso dispregiativo o comunque negativo; in realtà, il termine è quello con il quale si auto-designano coloro i quali vivono stanzialmente in Italia e che possiedono case.[1]
Rom (apocope della parola “romanì”) sono gli zingari nomadi provenienti dalla Romania (o dalle cosiddette zone balcaniche).
Nomade: termine generale per indicare gli zingari che non sono stanziali, quelli che si muovono su roulotte (ci sarebbe tanto da dire sulla differenza tra caravane e roulotte, mais laissons)
Gitano: (specifico) zingaro originario della Spagna
Tzigano: (specifico) zingaro della zona danubiana, solitamente suona il violino
Quindi il fatto che Tabucchi abbia scelto il termine gitano è perfettamente adeguato, trattandosi di uno zingaro proveniente dalla Spagna che vive in Portogallo (comunque nella penisola iberica). [2]
------------
[1] Almeno, secondo quanto mi fu detto dagli zingari Casagrande, alcuni dei quali frequentavano un liceo in cui ho insegnato alcuni anni fa.
[2]Che a Tabucchi stia particolarmente a cuore la sorte degli zingari, lo prova anche un testo da lui pubblicato due anni dopo, nel 1999, dal titolo: Gli Zingari e il Rinascimento; sottotitolo: vivere da rom a Firenze (Un libro a mezza strada tra il reportage e il pamphlet).